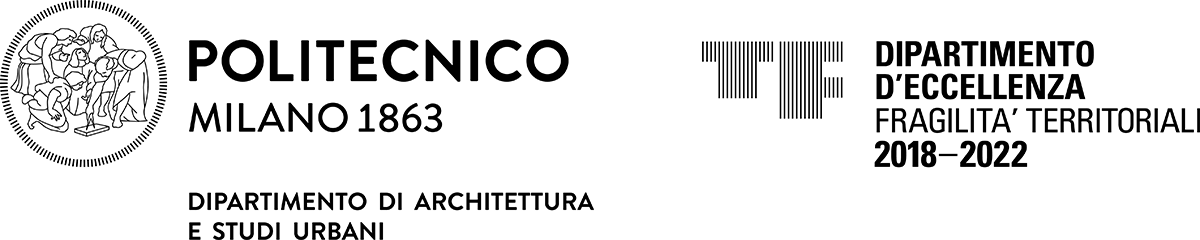I territori fragili e l'epidemia: riflessioni
Autore:
Giuliana CostaData:
9 Aprile 2020Risorsa e minaccia al tempo del covid-19
È da molto tempo che, come ricercatrice, mi occupo di coabitazione tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare e, nello specifico, di come viene interpretata e messa in atto nell’ambito delle politiche sociali. Si tratta di un tema poco esplorato, sia dalle scienze sociali, sia da chi si occupa di analisi delle politiche pubbliche, sia da quelle discipline che più da vicino guardano alle dimensioni dello spazio.
In Italia, uno dei Paesi più vecchi al mondo, il tema è entrato nel dibattito pubblico sul welfare con la diffusione delle assistenti familiari, le badanti, che hanno ormai da almeno 15 anni sopperito all’assenza o alla debolezza dei servizi domiciliari a favore di persone anziane non più autonome che hanno bisogno di supporto nello svolgimento della vita quotidiana. Si sono formati così nuclei di convivenza di persone, spesso diadi anziano/a-badante, che, proprio grazie al fatto di vivere insieme, restituiscono una risposta spesso efficiente ed efficace, specie in contesti culturali in cui ricoverare costituisce davvero una scelta di ultima istanza.
In realtà però, l’iper-prossimità riguarda una pletora di altri gruppi e bisogni sociali (Costa e Bianchi 2020). Sono diversi infatti i servizi che fanno della convivenza “sotto lo stesso tetto e dietro la stessa porta” (Costa 2016) un ingrediente fondamentale del proprio operato, sia nell’alveo delle politiche pubbliche, che della progettazione sociale di enti privati non profit come associazioni e cooperative nonché da parte di fondazioni.
La convivenza diventa risposta alla domanda che, secondo il mio punto di vista, emerge con urgenza allorquando si è di fronte ad un qualche deragliamento dei percorsi standard di vita che fa sì che le persone non possano più vivere nella propria casa o in quella della propria famiglia: “dove lo metto?”, “dove la metto?”. Il problema o, più spesso, i problemi che l’uscita “dai binari” – per stare nella metafora ferroviaria – porta con sé devono fare i conti con la questione degli spazi del vivere, dell’abitare, di un nuovo abitare. Non solo quindi “dove metto la mamma affetta da demenza?”, una domanda che si pongono centinaia di migliaia di persone in Italia, ma anche “dove metto mio figlio con gravi problemi psichici, non più in grado di stare con noi a casa?”.
La domanda riguarda non solo i singoli individui o le singole famiglie, ma anche la collettività allorquando si è di fronte a questioni inerenti a gruppi sociali più ampi: “come possiamo dare un po’ di dignità alle persone senza dimora? Come dare loro riparo, specie nei mesi invernali?”; “come e dove proteggiamo le donne vittima di violenza domestica o di tratta”?; “come e dove facciamo sì che migranti in fuga da guerre e persecuzioni possano riprendere fiato e sostare?”; “dove permettere alle persone di scontare pene alternative, fuori dal carcere?”; “come aiutare i neomaggiorenni in carico ai servizi sociali ad avere un’autonomia abitativa”? Gli esempi potrebbero moltiplicarsi a lungo.
Per tutti la dimensione del dove, diventa centrale e dirimente circa che tipo di società vogliamo, su quale base costruiamo i diritti di cittadinanza. E a ben pensare, buona parte dei servizi e delle risposte di welfare che hanno un contenuto anche residenziale, prevedono che le persone vivano insieme, in strutture comunitarie con il supporto di operatori del sociale o in alloggi di civile abitazione, in appartamenti condivisi. In questi luoghi di vita quotidiana si ha una stanza per sé o anche solo un posto letto e si dividono tutti gli altri spazi della domesticità, dalla preparazione e consumazione dei pasti allo svago.
Ecco perché la coabitazione rappresenta una dimensione importante delle politiche sociali e delle politiche abitative ad alto contenuto sociale (Tosi 2017). La nostra infrastruttura socio-assistenziale vede la presenza di diverse “case” – case rifugio, case di accoglienza, case famiglia e tante altre -, di comunità e di micro-comunità che fanno parte della rete dei servizi di welfare del nostro Paese.
Trovano anche corpo nell’operato di una miriade di piccole organizzazioni che lavorano per progetti, che provano a rispondere in modo innovativo a bisogni sociali emergenti, magari non caratterizzati da alti livelli di criticità, come ad esempio (ma è, di nuovo, un esempio tra tanti) quelli di chi si trova alle prese con una separazione o un divorzio e lascia la casa in cui viveva assieme al proprio coniuge. Luoghi da cui si riparte, lontani – quando le cose sono fatte per bene – da logiche istituzionalizzanti. Ancora, è sulla coabitazione che fanno perno i tanti progetti di accoglienza in famiglia, di affido o di ospitalità.
L’irrompere prepotente e veloce del Covid-19 ha però creato criticità inedite per chi vive assieme ad altri e per chi organizza a vario titolo, come parte della propria mission, diverse forme e modelli di convivenza tra i propri utenti. Le regole di distanziamento sociale e anti-contagio sono difficili da mettere in atto, oltre che nelle case di riposo, una vera emergenza nell’emergenza (Arlotti e Ranci 2020), una strage silenziosa dati gli altissimi tassi di contagio e mortalità in corso, anche in tutte le strutture collettive di carattere sociale che concentrano un alto numero di utenti, come i dormitori per persone senza dimora o in emergenza abitativa.
In tutta Italia sono in atto profonde riorganizzazioni dei servizi a bassa soglia e di quelli di secondo livello, come appunto le varie “case” che innervano, come affermato, una pluralità di interventi di welfare. Da una breve ricognizione fatta da me in quest’ultima settimana per mezzo dell’analisi della stampa e di interviste telefoniche ad operatori e gestori, le logiche con cui si sta procedendo a rispondere all’emergenza sanitaria per far sì che l’iper-prossimità non si trasformi in minaccia, sono principalmente due: da un lato, si sta cercando di diradare le presenze laddove possibile per mettere spazio tra le persone e porle nella condizione di rispettare la quarantena.
A Milano, da dove scrivo, il Comune si è per esempio trovato nella necessità di “alleggerire” Casa Jannacci, il grande dormitorio pubblico della città che normalmente ospita oltre 400 persone, per “evitare che [gli utenti] escano dalle strutture e per tutelare meglio sia loro che gli operatori che continuano a lavorare”, come ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali e Abitative, Gabriele Rabaiotti. Enti del terzo settore (in questo caso la cooperativa Spazio Aperto Servizi, gestore della Casa, ed Emergency) con la Protezione Civile hanno allestito gli spazi del centro sportivo Saini – chiuso ormai da febbraio – per ospitare 160 persone che lì sono già state traferite. Anche la tensostruttura del Social Music City nell’ex Scalo ferroviario di Porta Romana è stata adibita a questo scopo e vi sono state trasferite 120 persone. Chi non ha casa e “deve stare a casa” trova risposta in questo modo, nella possibilità di “stare” per tutto il giorno e non più solo per la notte o per alcuni momenti nel resto della giornata.
La seconda strategia è quella di agire delle forme di controllo ferree in molti dei luoghi del welfare da cui non si esce più per niente per evitare contagi che, se dovessero avvenire, metterebbero in difficoltà estrema i conviventi. L’introversione organizzativa e della vita quotidiana diventa protezione delle persone e della coabitazione. Nelle comunità di vario tipo si cerca di tutelare gli operatori che continuano a supportare le persone che vi abitano, imponendo anche a loro misure severe di autoprotezione, anche se in alcuni casi si è assistito a ritardi nella loro adozione.
Da ultimo mi preme segnalare come, in tempi di covid-19, si stiano creando nuovi spazi di coabitazione, proprio per fare fronte alle inedite domande circa il “dove lo metto?” che la pandemia sta per forza generando. Se da un lato le forme di convivenza sono sotto scacco – tutte, non solo quelle che si esplicano in grandi strutture, ma anche in quelle piccole – dall’altro la convivenza diventa innovazione, frutto di resilienza della città di fronte all’avanzare della pandemia.
Gli esempi sono tanti e si stanno moltiplicando di settimana in settimana ma mi limiterò ad indicarne tre. Primo: sempre nell’ottica di decomprimere Casa Jannacci, un’ulteriore struttura è stata messa a disposizione dei rider senza casa a Villapizzone. Lì un ex centro diurno che è stato riadattato a casa-famiglia e concesso gratuitamente a 20 giovani rider. Secondo: la cooperativa La Cordata, assieme al Comune di Milano, alla Cooperativa Comin, a Emergency e alla Diaconia Valdese, ha trasformato un piano del proprio residence in via Zumbiniin modo da accogliere 6 minori tra i 6 e i 14 anni, i cui genitori sono in ospedale perché positivi al coronavirus e che non hanno altri adulti di riferimento che possano prendersi cura di loro. Anche in questo caso sono in grado di ottemperare al protocollo sanitario vigente, garantendo la quarantena in isolamento a bimbi e ragazzi. Il terzo esempio è più generale e riguarda l’avviso pubblico lanciato il primo aprile dal Comune di Milano per “individuare strutture e alloggi di accoglienza per personale sanitario operativo e lavoratori nei servizi essenziali, cittadini sottoposti a quarantena (anche Covid-19 con sintomi lievi) che non hanno la possibilità di dimorare presso il proprio domicilio e persone in difficoltà sociale e abitativa”.
Alberghi ormai deserti stanno mettendo a disposizione le proprie camere, in stretta collaborazione con il Comune. Uno di questi è l’Hotel Michelangelo, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Lì potranno essere ospitati soggetti positivi al Covid, loro contatti stretti con quarantena obbligatoria che sono stati dimessi o non hanno avuto percorsi ospedalieri, persone che non hanno alloggi idonei alla quarantena, Forze dell’Ordine, persone senza fissa dimora o coloro che alloggiano temporaneamente in strutture comunitarie. Lo stesso vale per l’Hotel dei Cavalieri in Piazza Missori che ospiterà medici esposti al Covid-19 che non possono far rientro nei propri nuclei familiari a causa dell’impossibilità di garantire un sufficiente distanziamento sociale utile a proteggere persone conviventi. Da ultimo, anche la messa a disposizione dell’ostello della gioventù “Piero Rotta”, nel quartiere Qt8, permetterà a 200 persone di fare la quarantena.
Lo “stare a casa” per molti, in piena emergenza coronavirus, è “stare a casa con altri che non sono i propri familiari”. Con regole stringenti e tentativi di creare spazi di non contagio anche se non si tratta solo di una questione di prossemica. Le politiche sociali con una dimensione abitativa – quelle che danno luogo alle varie “case” e comunità di cui sopra – sono dunque oggi profondamente coinvolte dall’emergenza Covid-19. Lo sono anche tutte quelle soluzioni dell’ultima ora che vedono l’aggregazione di persone per dare loro una risposta sanitaria. Si tratta ora però di reinventare la coabitazione perché, come è stato affermato dal virologo Andrea Crisanti in un’intervista al Corriere della Sera, ora “per tornare a essere liberi e uniti bisogna per forza separarsi”.
Link: