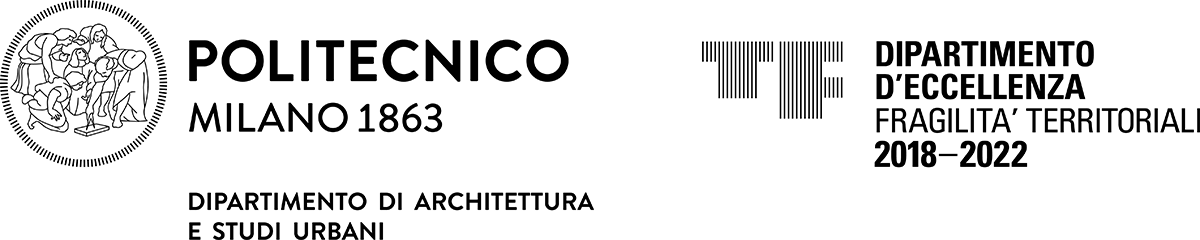I territori fragili e l'epidemia: riflessioni
Autore:
Marco BorsottiData:
15 Aprile 2020«… mi insinuavo lentissimamente in strati progressivi di collera e frustrazione, astio e incolpamento. Miseria, disoccupazione, casa, salute, assistenza agli anziani, istruzione, sicurezza, razzismo, problemi di genere, clima, pari opportunità: ogni vecchia questione della vita sociale restava irrisolta, a giudicare dal coro di voci come da striscioni, cartelli, magliette. Come dubitarne? Un’immagine protesa per ottenere qualcosa di meglio». Leggo queste righe nell’ultimo romanzo, Macchine come me, di Ian McEwan (che è anche l’ultimo libro che il Covid-19 mi ha concesso di acquistare, prima che su tutte le umane attività non di prima necessità si abbattesse, necessariamente, il lockdown) e mi chiedo se l’immagine che evocano sia il passato o il futuro.
Mentre sempre più voci ci dicono che nulla sarà più come prima, infatti, la domanda è se poi, una volta passata la paura, collante sociale potente, in realtà non tornerà tutto come prima, o quasi.
Perché dovrebbe essere tutto diverso? Certo, molti di noi non ce l’avranno fatta e il vuoto della loro assenza sarà incolmabile, mentre altri ancora di noi saranno più poveri di prima o saranno nuovi poveri e questa condizione drammatica andrà a consolidare quanto, nella sostanza, accadeva già prima, in un mondo dove abbiamo accettato che l’1% della popolazione mondiale possieda circa il 50% della ricchezza del pianeta (secondo l’ottava edizione del Global Wealth Report del Credit Suisse).
Quindi nulla sarà più come prima semplicemente perché la pandemia avrà modificato ancora in peggio l’equilibrio economico-politico del mondo? Oppure perché ci avrà dato l’opportunità di riflettere, di pretendere e imporre regole del gioco nuove, più sostenibili, più eque?
Veramente possiamo sperare che, per la prima volta nella storia umana, dal disastro emerga una società migliore, dove vorremo e sapremo tagliare con il passato e instaureremo rapporti migliori con la natura, i nostri prossimi e noi stessi?
Sapremo allora, finalmente pretendere stipendi non decorosi, ma anzi generosi per i medici e gli infermieri del servizio pubblico, che oggi sono i nostri angeli e fino a pochi giorni venivano aggrediti nei pronto soccorso per futili motivi; lo faremo per coloro che hanno sanificato ospedali e strade e noi chiusi in casa neppure li abbiamo visti, per i riders che ci hanno portato la pizza riciclando per giorni la stessa mascherina, per i cassieri e i poliziotti, per quelli che hanno tirato la cintura e rispettato le file?
E noi architetti? Torneremo a discutere, a fare infinite analisi e raccolte di casi studio e proiezioni e diagrammi o avremo la forza di affermare che il nostro è semplice e concreto mestiere del “fare” e non solo del dare “visioni” e quindi sapremo imporre nuovi termini di discussione, immediatamente legati alla concretezza del mettere in atto? Un “fare” sensibile, dove la qualità non può essere oggetto di contrattazione o bene superfluo, perché genera poesia e quindi bellezza e queste sono qualità necessarie alla vita. Pretenderemo dunque di essere tra quelli che agiscono, realizzando nei piccoli e nei grandi progetti forme innovative di abitabilità – perché questo è il nostro mandato: rendere il mondo abitabile?
Mi sorprendono i molti colleghi che oggi, nella costrizione contingente e brutale dell’#iorestoacasa, proprio quest’ultima riscoprono e pronunciano anche quella parola, interni, che nella normalità hanno scordato o relegato ai margini del pensiero.
L’isolamento, il confinamento (perché questo vuol dire lockdown), paradossalmente ci ricorda che l’architettura è questione di resa abitabile dello spazio e che abitare è stato, ai nostri primordi, l’atto di dotarsi di un rifugio, di un luogo sicuro in cui rintanarsi. Per questo è paradossale la riscoperta dello spazio interno ora. L’interno è sempre stato l’esigenza primaria: il conformare un habitat, condizione esistenziale del vivere e fortunatamente, nell’evoluzione della specie, non più esclusivamente del sopravvivere. Allora sono d’accordo con Massimo Cacciari quando afferma «Lasciate stare le puttanate che raccontano i nani e i ballerini della televisione. Chi può stare bene a casa? Che fantasie idiote sono mai queste? Solo un irresponsabile può avere l’animo sereno in un momento così. In queste condizioni, la casa è un inferno» (Huffingtonpost, 05/04/2020)
Perché questo è il momento in cui siamo ‘costretti’ a casa, in cui occupiamo costantemente il nostro stesso spazio primario perché è un virus che ce lo impone. Sono i giorni in cui «…soltanto dall’interno possiamo avvicinarci gli uni agli altri – e la finestra a cui si affaccia la nostra “interiorità” sono gli occhi». (Slavoj Žižek, Virus) Dunque abitiamo sotto costrizione e solo in questa condizione riscopriamo l’abitare stesso, il senso dei nostri interni, la capacità di adattarli e reinventarli, di trasformarli e riattrezzarli, facendoli diventare uffici, aule di scuola, luoghi per lo sport, la musica, la lettura, lo svago: estensioni del nostro pensiero e delle nostre attitudini?
L’interno è il “componente principale del progetto” (Achille Castiglioni insegna) di architettura e ciò che sta al principio delle cose non può mai essere negletto perché ne costituisce il fondamento: l’abitabilità dello spazio deve essere sempre la componente principale delle nostre intenzioni. Prima dell’emergenza, prima della contingenza. Nella quotidianità.
Proprio dalle nostre case, dal nostro principio personale di abitabilità, oggi dobbiamo affrontare la sfida della pandemia come una chiamata definitiva alla ridefinizione della qualità della vita. Un principio utopico? Sicuramente, ma di fronte a un sistema socio-politico collettivo che non ha saputo evidentemente reggere quest’urto, forse abbiamo bisogno di due vaccini: uno per il corpo e l’altro, una nuova Utopia, per la mente.
Perché questa contingenza drammatica non è soltanto un evento da non dimenticare: «Una memoria che tutto conserva in fondo non conserva nulla» (Judith Schalansky, Inventario di alcune cose perdute). Il mero non dimenticare deve essere sovvertito in un atto di ripensamento profondo, nobilitando l’azione del ricordo con il ricordo dell’azione. Come ha scritto Alessandro Baricco «Ora dobbiamo passare ad altro: pensare, capire, leggere il caos e prenderci il rischio di dare a tutti qualche certezza: questo è il mestiere degli intellettuali. (…) Dobbiamo passare all’audacia». (La Repubblica, 26/03/2020). Altrimenti l’alternativa, insostenibile, sarà quella di insinuarsi lentissimamente tra quegli strati di collera descritti da McEwan.
«Non si ritorna alla normalità, la nuova “normalità” dovrà essere ricostruita sulle macerie della vita di una volta, oppure ci ritroveremo in una nuova barbarie di cui già si scorgono distintamente le prime avvisaglie. (…) dovremo sollevare la domanda: che cosa proprio non va nel nostro sistema (…) Dare una risposta a questa domanda richiederà molto di più che nuove forme di assistenza sanitaria globale». (Slavoj Žižek, Virus)
Moltissimi sono gli squarci apertisi nella nostra quotidianità del sociale. Varchi in cui spingere profondamente il nostro pensiero. Siamo chiamati a ridisegnare molte delle nostre forme di socialità, a reinventare il nostro nomadismo, a rivedere i termini del fornire assistenza, a ridiscutere la finalità del nostro insegnare…
Provo ad annotare dei dualismi, proponendoli a tutti noi come luoghi di riflessione, spazi mentali da rendere abitabili con nuove utopie, istanze di cambiamento.
– disponibilità di tempo vs disponibilità di consumi
(anche ora che le professionalità realmente utili si sono rivelate, ancora l’efficienza si commisura esclusivamente sul mero guadagno?)
– lavori produttivi vs lavori burla
(questi ultimi nell’accezione che ne dà Rutger Bregman in Utopia per realisti; ovvero del drastico ridimensionamento delle competenze basate sul monetizzare il niente)
– nanismo vs gigantismo
(è realmente sano e necessario che prevalga il principio della winner-take all society, che fa tabula rasa delle realtà più piccole, che tutto monopolizza e livella, annullando la diversità come ricchezza reale?)
– didattica dei valori vs didattica delle competenze
(è ancora plausibile idealizzare forme di conoscenza ottimizzate per il mercato del lavoro e non per il mercato della vita, ovvero l’architetto e l’ingegnere – giusto per fare un esempio a caso – sono puri ‘tecnocrati’ o anche etica, filosofia, arte sono le loro pietre angolari?)
– silenzio vs rumore
(strade meno affollate, traffico azzerato, canali e mari più lipidi; ovvero della necessità di nuove dinamiche d’uso di ogni scala abitabile, a partire da quella estesa del pianeta)
– comunicazione vs rumore di fondo
(l’emergenza ha richiesto forme differenti di comunicazione, con livelli diversificati d’urgenza, mentre la distanza sociale ci ha sottratto i potenti mezzi della linguistica corporale e di prossimità, dandoci in cambio quella traslata delle tecnologie, ma anche nel prossimo futuro le modalità di erogazione dei contenuti sono destinate a riassettarsi secondo modalità ibride e innovative)
– individualità vs collettività
(distanziamento sociale: oggi un obbligo sanitario, morale e legale, ma domani? Quanto inciderà sulla condizione dei nostri spazi, che forse solo oggi comprendiamo appieno nel loro essere stati strutturati per una presenza collettiva massiccia, perfino indiscriminata, con tutte le bellezze e gli squilibri che ne sono conseguiti e che oggi potrebbero essere riconformati?)
– fragilità vs robustezza (da tempo ormai indaghiamo le fragilità – come architetti soprattutto quelle territoriali –, ma oggi, forse, dovremmo ribaltare il paradigma ed esplorare le supposte ‘robustezze’ dei nostri sistemi di vita, giacché da un lato è evidente che molte di esse hanno ceduto e dall’altro, adesso un concetto ben più esteso di ‘fragilità’ ci coinvolgerà tutti, rendendo quest’ultima un paradigma del quotidiano (da cui il ridisegno delle abitudini, delle tempistiche, degli scambi e soprattutto dei ‘luoghi’).
«I pezzi ci sono tutti, sulla scacchiera, fanno tutti male, ma ci sono: c’è una partita che ci aspetta da un sacco di tempo. Che sciocchezza imperdonabile sarebbe avere paura di giocarla». (Alessandro Baricco, La Repubblica, 26/03/2020)