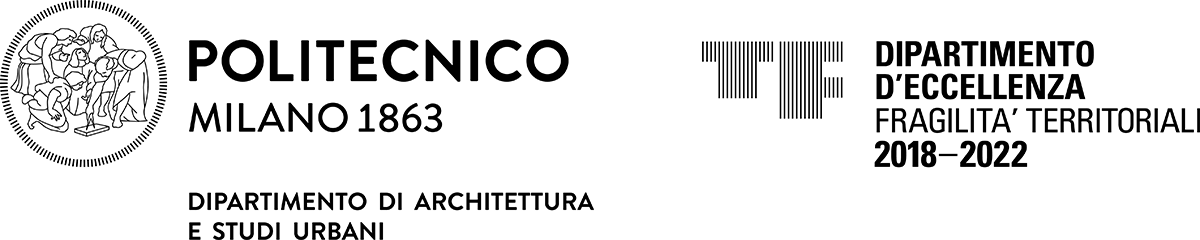I territori fragili e l'epidemia: riflessioni
Autore:
Annunziata Maria OteriData:
22 Aprile 2020“Ad Armungia – scrive Roberto Cabboi in un post su facebook del 14 marzo scorso – fino a qualche giorno fa potevi andare a fare la spesa nelle piccole botteghe del paese, prenderti cura dell’orto o del giardino, fare una passeggiata in campagna, andare al tabacchino da Gigi, andare al bar da Cristof. Adesso puoi fare la spesa nelle piccole botteghe del paese, prenderti cura dell’orto o del giardino, fare una passeggiata in campagna, andare al tabacchino da Gigi. Ecco purtroppo abbiamo momentaneamente perso la possibilità di andare al bar da Cristof”.
Fa eco Vito Teti, dal balcone della sua casa a San Nicola di Crissa, un nucleo storico di poche anime alle pendici del Monte Cucco, una ventina di chilometri da Vibo Valentia, dove la pandemia ha confermato gli stessi silenzi e le stesse solitudini di prima. Il virus, scrive Teti, colpisce periferie urbane inquinate e invivibili, città sovraffollate e caotiche, ma si “avvina” anche su paesi già malati di abbandono (Un etnografo nel suo paese e nella sua casa ai tempi del coronavirus, è del 14 marzo 2020).
In questi luoghi – i numerosi piccoli centri spopolati della nostra Italia – strade deserte, silenzio e tempo sospeso sono una consuetudine, non l’eccezione dettata dall’emergenza. Nessuno in questi giorni posta video o immagini di piccoli centri vuoti, perché non fanno notizia, come non fa notizia la solitudine di chi li abita; mentre le immagini di Milano, Brescia o Firenze, bellissime ma disperatamente deserte, hanno fatto il giro del mondo.
read-more
La riflessione è senz’altro ovvia: per chi è abituato a vivere con poco (niente cinema, teatri e neanche persone con cui incontrarsi) il disagio del lockdown è modesto o inesistente. In questi luoghi si fa quello che si faceva già prima, quindi, paradossalmente, al momento si vive meglio che in città normalmente affollate e oggi improvvisamente segregate. Ciò a maggior ragione, poi, da quando ci siamo accorti che il virus non distingue tra periferia e centro; non muoiono solo gli anziani della val Seriana ma anche i giovani che vivono a Milano. In effetti è vero che chi ha potuto, incluso chi scrive, ha deciso di affrontare la quarantena lontano dalle città infette – dove magari abitualmente vive per lavoro – rientrando nei luoghi di origine. Non è solo l’idea di una vicinanza fisica alla propria famiglia che ha spinto i “rientranti” a muoversi in piena emergenza, o la certezza di andare incontro a una gestione più semplice del quotidiano (niente più code estenuanti per la spesa, ad esempio, perché quello che ti serve lo compri al negozietto dell’amico di infanzia, o lo raccogli nell’orto dietro casa). Vi è anche, credo, nella spinta a “rientrare” una percezione differente del pericolo di contagio; d’altra parte, i dati stanno dimostrando che la possibilità di contrarre il virus nelle aree meno popolate, a meno di alcune eccezioni e qualunque ne sia la ragione, è minore. Per certi versi, poi, nei luoghi dove il numero dei contagi si è attestato su cifre ragionevoli, la gestione dell’emergenza si è rivelata più semplice: lì dove rimane ancora qualche traccia di una rete sanitaria territoriale, ad esempio, è stato possibile gestire i contagi con terapie domiciliari, riducendo la pressione negli ospedali e dando ragione a chi, già in tempi non sospetti, scommetteva su “medici scalzi” e “sentinelle di comunità” per recuperare una dimensione territoriale della cura (Luca Tantillo, Il paese remoto dopo la pandemia, https://www.leggiscomodo.org/il-paese-remoto/). Abbiamo poi verificato che seppure il digital divide si conferma un problema nelle aree interne, con un po’ di organizzazione, la didattica a distanza è possibile anche in una piccola frazione della val Soana e che, in fin dei conti, le complicazioni che le famiglie hanno dovuto affrontare per far studiare i loro figli in quarantena, pur nella diversità dei casi, hanno riguardato grandi e piccoli centri, costa e interno, senza distinzioni.
Del valore del territorio, delle comunità, della prossimità si è dunque ripreso a parlare con un certo ottimismo in questi giorni, sottolineando per contrasto e con quel tanto di cinica soddisfazione, la fragilità di una regione, la Lombardia, fino a ieri inarrestabile motore dello sviluppo del nostro Paese e oggi in crisi per l’inaspettata invadenza del virus (M. Imarisio, Nelle due Italie del coronavirus l’insofferenza (sbagliata) verso la Lombardia, “Il Corriere della Sera, 16 aprile 2020).
Sembrerebbe pertanto profilarsi una rivincita dei territori interni, che molti vorrebbero cavalcare contro il fallimento del modello città, auspicando addirittura che i “rientranti” si trasformino in “ritornanti”. È un ottimismo che inevitabilmente si ridimensiona se, lasciando da parte i dati e le stime ufficiali – peraltro in molti casi contrastanti – ma anche quel soffio di positività portato da chi è rientrato, si rifletta su questioni meno quantificabili (e sulle quali è senz’altro prematuro pensare a un bilancio realistico), come ad esempio il fatto che l’epidemia abbia amplificato, anziché ridurle, le paure generate dalle diseguaglianze sociali: “se esplodesse qui, sarebbe una strage” si sente ripetere tra chi abita nei territori interni, nella precisa consapevolezza della carenza di servizi essenziali, dell’assenza dello Stato e dell’inadeguatezza degli amministratori locali. Insomma, oltre a mostrare la fragilità delle nostre città, l’epidemia ci impone di non dimenticare, di là dei segnali positivi che ovunque si raccolgono, la fragilità dei territori di margine.
Pertanto, se il nodo della questione è aree interne versus città, difficilmente il dibattito sortirà qualche esito, come raramente portano frutti le contrapposizioni e le facili rivalse. Finita l’emergenza, forse troppo breve, seppur drammatica, per avere effetti concreti su politiche e comportamenti, torneremo a verificare che le aree interne sono quello che erano prima della pandemia e che, nella maggioranza dei casi, chi vi si è rifugiato per sfuggire al pericolo di un contagio non vi troverà le condizioni per “restare”. A conferma di ciò basta osservare, come peraltro opportunamente fanno Coppola, Curci e Lanzani su questo blog (Covid 2019. È necessario elaborare politiche differenziate nei diversi territori e guardare diversamente al sud d’Italia, 16 aprile 2020) che sia nell’organizzazione dell’emergenza che nei primi, confusi programmi post-quarantena, le politiche nazionali di gestione del territorio non sembrano guardare alle aree interne o quelle fragili del sud d’Italia come a potenziali risorse per la ripartenza. Se guardiamo alle città, poi, in fondo, le fragilità che la pandemia ha lasciato emergere in modo così dirompente, erano già per molti versi latenti.
Non ci sono dunque né vincitori, né vinti.
Riducendo di molto la portata del nostro sguardo ambizioso sul futuro, ci sarebbe invece da osservare e analizzare un fenomeno di questi giorni, che riguarda la capacità delle comunità, piccole o grandi, di quartieri di città o di villaggi, di reagire riorganizzandosi intorno al tema della cura e della solidarietà, mostrando peraltro risorse inaspettate. Forse è vero che questi “piccoli conati di autodifesa” (G. Carrosio, Cittadinanza e aree interne in Italia nell’ambito della giornata di studi Un’agenda di ricerca per le fragilità territoriali, DAStU Dipartimento d’eccellenza Fragilità territoriali, Politecnico di Milano, 26 marzo 2019) trovano, e non da ora, terreno più fertile nei territori che da tempo combattono marginalità e diseguaglianze civili, perché quando si ha poco si è costretti a sopperire con creatività e ingegno. A maggior ragione dunque, questo non è il tempo della contrapposizione ma della condivisione di esperienze e risultati. Si tratta, è vero, di microprogetti che hanno probabilmente scarsa incidenza sulla portata dirompente e drammatica del fenomeno Covid, che tuttavia ci invitano a riflettere sul ruolo delle risorse di comunità e sul fatto che indipendentemente da dove le si pratichino, sono un importante segnale di resistenza (e di speranza) nei tempi difficili che ci aspettano. A chi, come noi, fa ricerca sul territorio, si offre dunque l’occasione di raccogliere e interpretare questi fenomeni, spontanei, è vero, ma molto spesso più efficaci delle politiche concertate, e di verificare eventualmente la possibilità di trasformarli in qualcosa di più. Nella fase di post-emergenza (o di semi-emergenza) che ci attende questo sarebbe già un gran risultato.
read-less